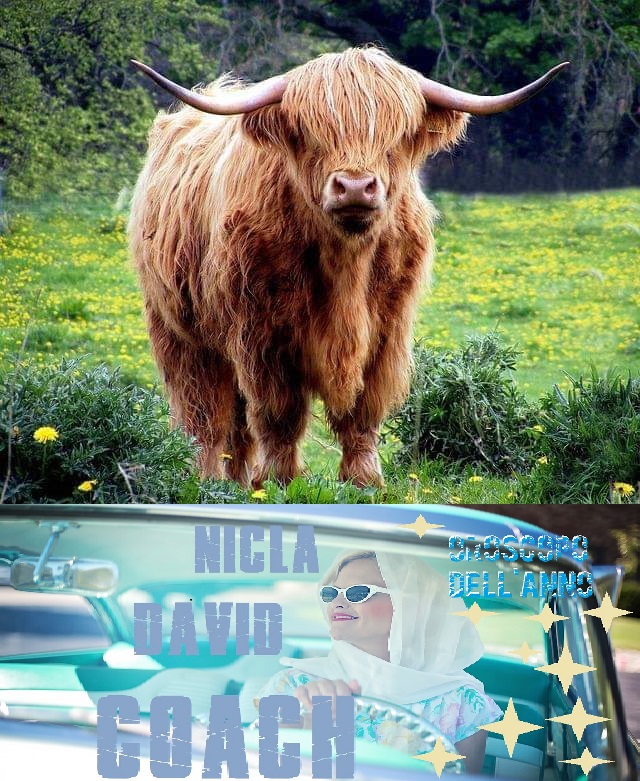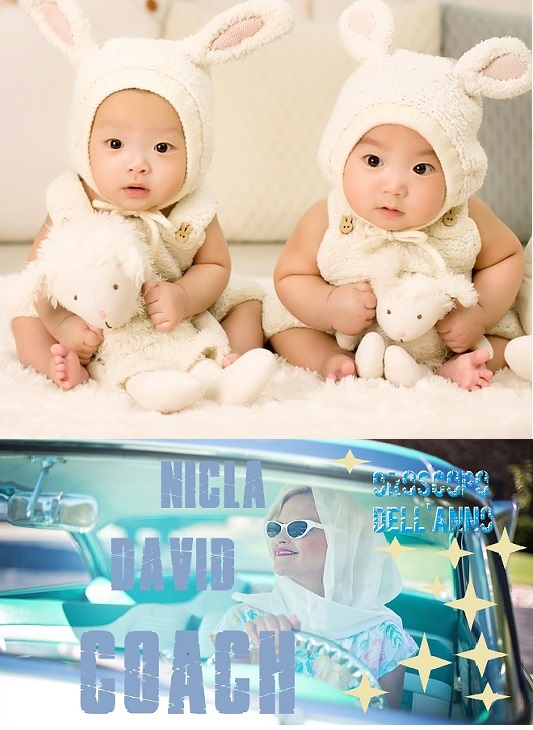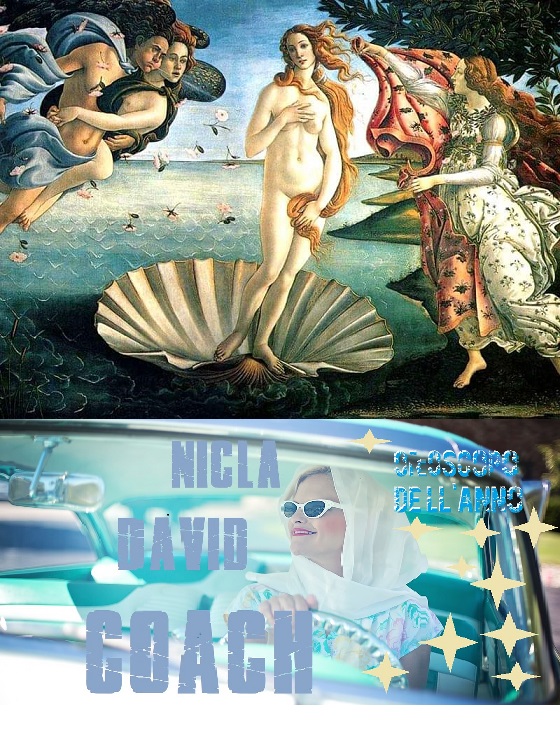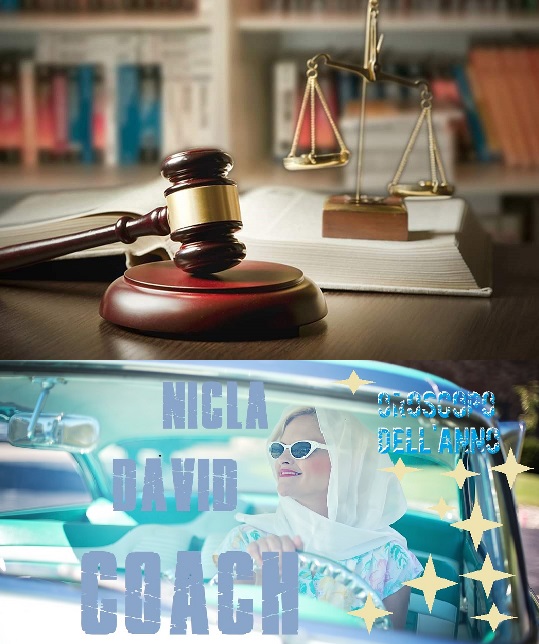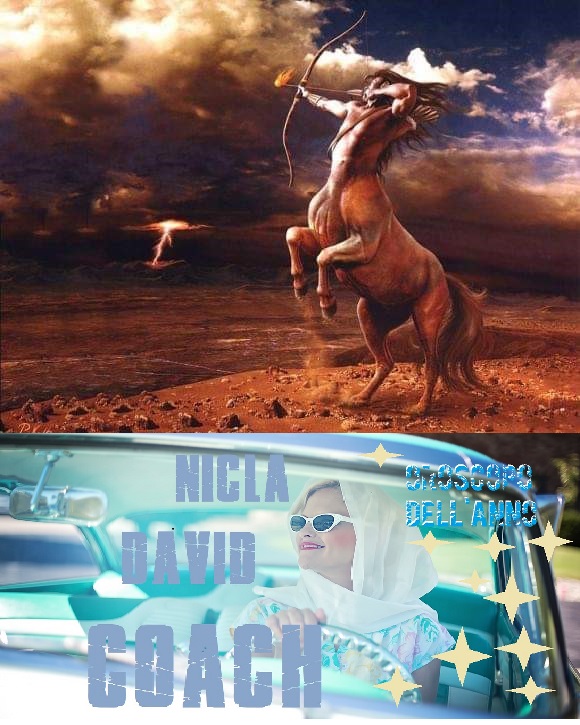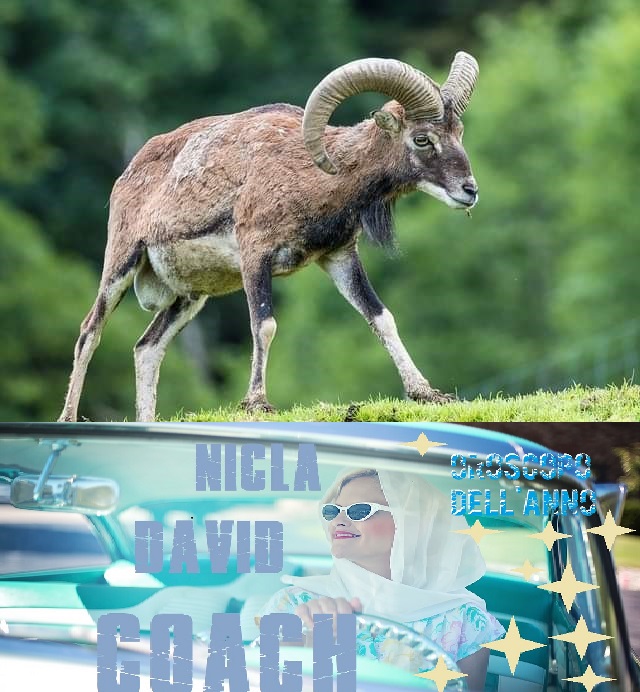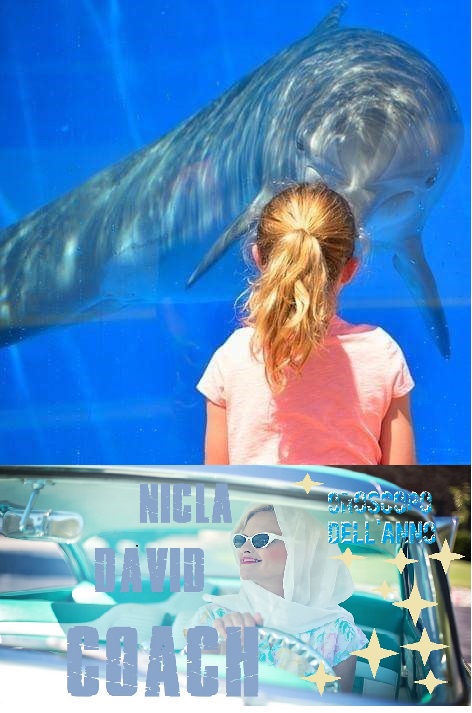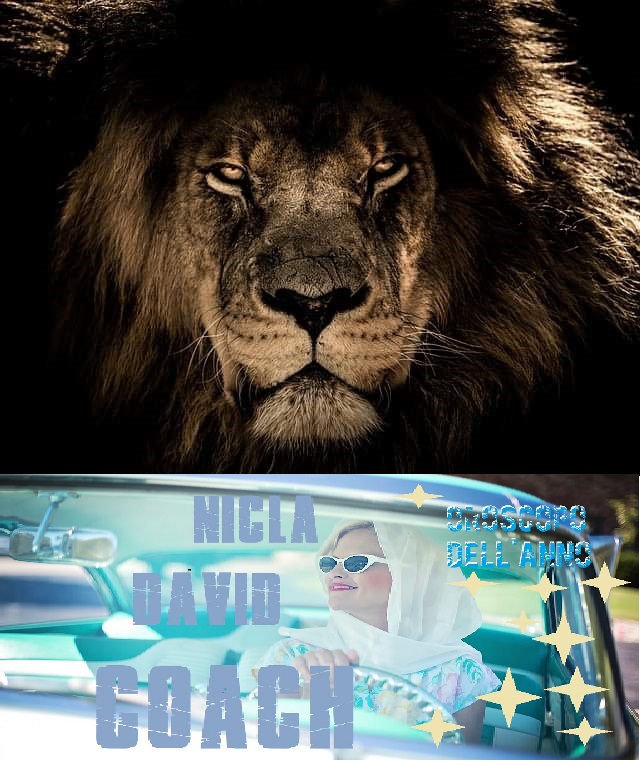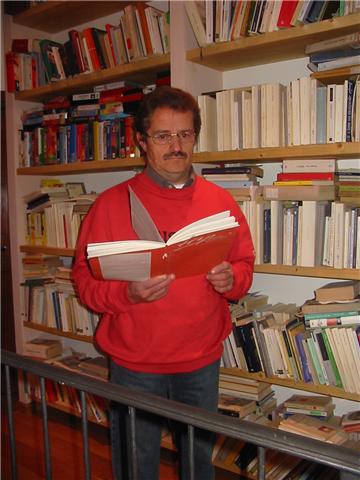
Vignettopoli
IL FILOSOFO DELLA TENEREZZA

e tuttavia esso non esclude, anzi agevola, la constatazione subitanea di una dichiarazione d’amore alla filosofia e alla vita: “par cœur”, come afferma Roberto Borghesi. Ci si avvicina a questo libro con la sensazione di uno scritto ‘ leggero ‘ ed ermetico ad un tempo, che lascia ‘ sbigottito ‘ il lettore. Questi è colto dalla certezza immediata che non sarebbe stato possibile – quand’anche lo si fosse voluto – disciplinare tale stesura ‘ispirata’ con la sollecitudine del filologo, poiché la scrittura di Roberto Borghesi, ricca di fratture, note, citazioni e in cui le imprecisioni ‘precisano’, è volutamente a-nomala, fino a giungere ad una perfetta integrazione ‘decostruttiva’ di riflessione, discorso speculativo, esegesi e scrittura, atta a scardinare i nessi logico-semantici. Il furore che muove lo scritto è di per sé dunque atto inemendabile che marca l’anticonformismo ribelle, lo sforzo prometeico di slegarsi dalle catene formali di colui che lo ha composto.
 Ma abbandoniamoci ad alcune considerazioni esteriori di ordine ‘cabalistico’ che si attagliano alla lettura decostruzionista che sta alla base di molte delle laconiche corrispondenze, delle tenaci riflessioni dell’autore. Il testo contava, nella veste con cui si è presentato a chi scrive, quelle ‘ canoniche ‘ 365 pagine, nel numero già assai fascinose a primo acchito e che avrebbero permesso di reiterare la fantasiosa metafora ‘ elefantina ‘ dello Zaratustra. Un libro forte di tale numero di pagine pare quasi simbolicamente volerci offrire una pagina al giorno: “formula” o “ricetta” – come afferma in altro contesto il nostro Borghesi – per farmaco medicamentoso, preparato terapeutico in posologia giornaliera, come psico-analiticamente si vorrebbe. Ma v’è dell’altro. L’autore afferma di aver impiegato 35 anni a scriverlo: è stato dunque il suo il vero sforzo elefantiaco, e qui il pensiero non può non andare all’immagine di Nietzsche medesimo, che nei suoi ‘ calcoli ‘ sullo Zaratustra (che Roberto scrive alla francese “Zarathoustra”, semmai ci fosse bisogno di un’ulteriore dichiarazione delle sue fonti!) paragonava il suo scritto alla gravidanza d’elefante, e la cui composizione lui faceva coincidere con la “sacra ora” della morte di Wagner a Venezia (così in Ecce homo, Perchè scrivo così buoni libri). Concesso dunque che la gravidanza ‘ elefantina ‘ consti di diciotto mesi e che Nietzsche abbia lavorato alla propria opera più profetica esattamente un tal tempo, dicendosi buddisticamente “elefante” egli stesso, noi siamo persuasi che per Roberto Borghesi lo sforzo di aver scritto questo libro sia stato altrettanto, e forse più, immane: e tuttavia va detto che aver tenuto nel cassetto quest’opera ben 35 anni non è equivalso a ‘ scordare ‘, bensì a ‘ filtrare ‘ una rifrazione “per tutti e per nessuno”, che si ‘ nasconde ‘ e che porta la “maschera”, anzi la maschera sotto l’altra maschera, e che nonostante ciò vuole, anzi reclama di essere compresa. Ma qualcosa ancora va detto: la scrittura di Roberto è giunta ad una ‘ gravidanza ‘ ben più longeva anche al fine che il carattere di questa divenisse di ordine terapeutico prima ancora che filosofico, percorso salvifico, in cui lo sforzo spasmodico di penetrazione razionale si alterna felicemente ad un atto di liberazione continuo, talvolta nietzscheanamente vicino alla danza: “Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde” (“Potrei credere solo ad un Dio che sapesse danzare”). In questo senso a nostro avviso il capitolo “Della tenerezza” è quello che più avvicina il lettore alla concezione – e anche all’indole – dell’autore, così assorbito a fornirci le ragioni di un atto provvidenziale e preoccupato di mettere in chiara evidenza l’assunto – fondamentale – della sua lettura nietzscheana, che pone la grandezza in alternativa alla potenza e la cui conditio è “la solitudine più assoluta”. E se vi è stata categoria esistenziale congeniale a Nietzsche – il filosofo che fece credito a se stesso – , essa è proprio quella della solitudine, categoria che Roberto Borghesi incarna e declina assieme alla categoria della sofferenza: “C’è della pena, ci vuole della tenerezza”…Concludiamo con la metafora intrapresa all’inizio: in Zaratustra Nietzsche afferma a proposito dell’elefante: “Wunderlich mühn sie sich ab, einem Elephanten gleich, der sich müht auf dem Kopf zu stehn”. “Auf dem Kopf zu stehn” “: stare sulla propria testa, andare a testa in giù. Questo è il tema sovrastante della lettura ‘a-tipica’ di Roberto: capovolgere l’ordine e appropriarsi di una percezione nuova, ricondotta ad un senno superiore, sfuggente e incalcolabilissimo. È la sostanza che abbagliò Heidegger, tratta per l’appunto da un altro grande della drammaturgia tedesca, quel Georg Büchner anticipatore della modernità, che lascia camminare il suo eroe Lenz ‘ sulla testa ‘ formulando il grandioso distico: “Wer auf dem Kopf geht, der hat den Himmel als Abgrund”: “chi cammina a testa in giù, ha il cielo come abisso”, segno estremo di arte indomita e di inesausta speranza di giungere ad un “di più”, che è per Roberto – filosofo son malgré e uomo di cultura ed impegno – esercizio quotidiano di apprendistato, di pratica e di tirocinio, alla filosofia, al dilemma inquietante del mondo e alla vita. Auguriamo a Roberto che la vista dell’abisso sia a lui ontologicamente – e terapeuticamente – occasione per scorgere l’infinitezza dell’andare “a testa in giù”, non già come pietra di scandalo, ma per avvistare l’infinito e tentare la scommessa kierkegaardiana di fronte alla vertigine, quella “simpatia antipatica / antipatia simpatica” che sempre accompagna chi – come Friedrich Nietzsche e come Roberto Borghesi – osi esporsi al vento freddo delle vette e scorgere oltre il limite.Inno alla vita è allora questo testo, vera e propria “gaya scienza” psicologica, filosofica ed esistenziale ad un tempo.
Ma abbandoniamoci ad alcune considerazioni esteriori di ordine ‘cabalistico’ che si attagliano alla lettura decostruzionista che sta alla base di molte delle laconiche corrispondenze, delle tenaci riflessioni dell’autore. Il testo contava, nella veste con cui si è presentato a chi scrive, quelle ‘ canoniche ‘ 365 pagine, nel numero già assai fascinose a primo acchito e che avrebbero permesso di reiterare la fantasiosa metafora ‘ elefantina ‘ dello Zaratustra. Un libro forte di tale numero di pagine pare quasi simbolicamente volerci offrire una pagina al giorno: “formula” o “ricetta” – come afferma in altro contesto il nostro Borghesi – per farmaco medicamentoso, preparato terapeutico in posologia giornaliera, come psico-analiticamente si vorrebbe. Ma v’è dell’altro. L’autore afferma di aver impiegato 35 anni a scriverlo: è stato dunque il suo il vero sforzo elefantiaco, e qui il pensiero non può non andare all’immagine di Nietzsche medesimo, che nei suoi ‘ calcoli ‘ sullo Zaratustra (che Roberto scrive alla francese “Zarathoustra”, semmai ci fosse bisogno di un’ulteriore dichiarazione delle sue fonti!) paragonava il suo scritto alla gravidanza d’elefante, e la cui composizione lui faceva coincidere con la “sacra ora” della morte di Wagner a Venezia (così in Ecce homo, Perchè scrivo così buoni libri). Concesso dunque che la gravidanza ‘ elefantina ‘ consti di diciotto mesi e che Nietzsche abbia lavorato alla propria opera più profetica esattamente un tal tempo, dicendosi buddisticamente “elefante” egli stesso, noi siamo persuasi che per Roberto Borghesi lo sforzo di aver scritto questo libro sia stato altrettanto, e forse più, immane: e tuttavia va detto che aver tenuto nel cassetto quest’opera ben 35 anni non è equivalso a ‘ scordare ‘, bensì a ‘ filtrare ‘ una rifrazione “per tutti e per nessuno”, che si ‘ nasconde ‘ e che porta la “maschera”, anzi la maschera sotto l’altra maschera, e che nonostante ciò vuole, anzi reclama di essere compresa. Ma qualcosa ancora va detto: la scrittura di Roberto è giunta ad una ‘ gravidanza ‘ ben più longeva anche al fine che il carattere di questa divenisse di ordine terapeutico prima ancora che filosofico, percorso salvifico, in cui lo sforzo spasmodico di penetrazione razionale si alterna felicemente ad un atto di liberazione continuo, talvolta nietzscheanamente vicino alla danza: “Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde” (“Potrei credere solo ad un Dio che sapesse danzare”). In questo senso a nostro avviso il capitolo “Della tenerezza” è quello che più avvicina il lettore alla concezione – e anche all’indole – dell’autore, così assorbito a fornirci le ragioni di un atto provvidenziale e preoccupato di mettere in chiara evidenza l’assunto – fondamentale – della sua lettura nietzscheana, che pone la grandezza in alternativa alla potenza e la cui conditio è “la solitudine più assoluta”. E se vi è stata categoria esistenziale congeniale a Nietzsche – il filosofo che fece credito a se stesso – , essa è proprio quella della solitudine, categoria che Roberto Borghesi incarna e declina assieme alla categoria della sofferenza: “C’è della pena, ci vuole della tenerezza”…Concludiamo con la metafora intrapresa all’inizio: in Zaratustra Nietzsche afferma a proposito dell’elefante: “Wunderlich mühn sie sich ab, einem Elephanten gleich, der sich müht auf dem Kopf zu stehn”. “Auf dem Kopf zu stehn” “: stare sulla propria testa, andare a testa in giù. Questo è il tema sovrastante della lettura ‘a-tipica’ di Roberto: capovolgere l’ordine e appropriarsi di una percezione nuova, ricondotta ad un senno superiore, sfuggente e incalcolabilissimo. È la sostanza che abbagliò Heidegger, tratta per l’appunto da un altro grande della drammaturgia tedesca, quel Georg Büchner anticipatore della modernità, che lascia camminare il suo eroe Lenz ‘ sulla testa ‘ formulando il grandioso distico: “Wer auf dem Kopf geht, der hat den Himmel als Abgrund”: “chi cammina a testa in giù, ha il cielo come abisso”, segno estremo di arte indomita e di inesausta speranza di giungere ad un “di più”, che è per Roberto – filosofo son malgré e uomo di cultura ed impegno – esercizio quotidiano di apprendistato, di pratica e di tirocinio, alla filosofia, al dilemma inquietante del mondo e alla vita. Auguriamo a Roberto che la vista dell’abisso sia a lui ontologicamente – e terapeuticamente – occasione per scorgere l’infinitezza dell’andare “a testa in giù”, non già come pietra di scandalo, ma per avvistare l’infinito e tentare la scommessa kierkegaardiana di fronte alla vertigine, quella “simpatia antipatica / antipatia simpatica” che sempre accompagna chi – come Friedrich Nietzsche e come Roberto Borghesi – osi esporsi al vento freddo delle vette e scorgere oltre il limite.Inno alla vita è allora questo testo, vera e propria “gaya scienza” psicologica, filosofica ed esistenziale ad un tempo.
- VIA
- Roberto Borghesi