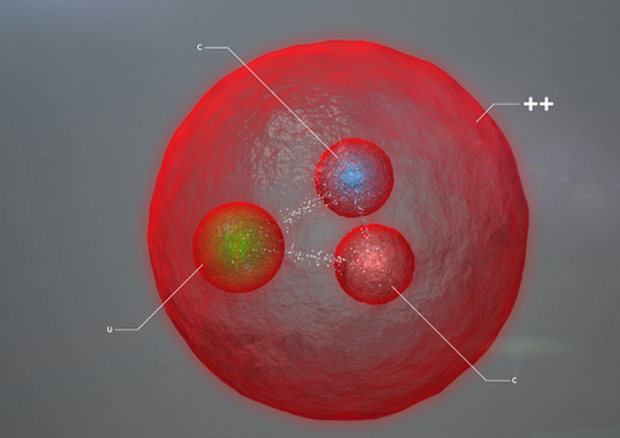Vignettopoli
Attenti al lupo

I bambini moderni hanno smesso, ormai, da tempo di credere in Babbo Natale e le loro mamme si sono rassegnate all’idea che il principe azzurro non esiste. L’umanità intera, indipendentemente dall’età, dal sesso, dall’estrazione sociale e culturale non ha mai accantonato, neppure un attimo, la convinzione che il lupo cattivo non è solo una metafora, ma rappresenta una realtà, alle volte, molto più vicina a noi di quanto possiamo immaginare.
Questo, forse, uno dei motivi che giustifica il perché i programmi televisivi che vivono con i fatti di cronaca nera stiano ottenendo audience e share così alti. Una ulteriore dimostrazione di come sia diventata morbosa la nostra curiosità verso casi drammatici come quelli di “Avetrana”, “Brembate Sopra”, “Perugia”, “Garlasco” o “Cogne”. Nomi di paesi, cittadine che, fino a poco tempo fa, non ci dicevano nulla, nemmeno dal punto di vista geografico, ma, che, oggi, sono diventati l’emblema di gravi episodi di cronaca nera. Il simbolo di efferati omicidi, oppure, come l’ultimo caso accaduto a Brembate Sopra, della scomparsa senza un evidente perché, di una esemplare adolescente con la passione per la danza.
La cronaca nera ha sempre goduto di un certo interesse. Ma, perché, oggi, quell’interesse si è trasformato in perversa attrazione verso avvenimenti così tragici?
Il fatto di cronaca nera altro non è che la rappresentazione dell’orrore che vive in ciascuno di noi: nel lato più oscuro della nostra psiche convivono, latenti, istinti di morte e desideri necrofili inconfessabili che, attraverso la spettacolarizzazione del male, si materializzano, chiari e indelebili davanti ai nostri occhi.
Non tutti i telespettatori, si identificano con la vittima, una parte, purtroppo, si riconosce nel carnefice. È altissimo il rischio di emulazione connesso all’interesse per fatti omicidiari cruenti. Pensiamo all’avvenimento di Jessika Davies, nipote ventottenne di un noto e milionario parlamentare, che nel 2007 ammise di avere ucciso, a Parigi, il suo amante, ispirandosi ai fatti di “Perugia”.

Giornalisti, cronisti, mass media hanno una grande responsabilità, quella di capire che tra il loro pubblico potrebbero esserci anche personalità disturbate, che dal dettaglio massmediatico potrebbero venire influenzate se non addirittura ispirate.
È atavico nell’uomo essere attratto da ciò che fa paura: paura della sofferenza, del dolore, ma soprattutto, della morte.
Secondo il cronista Enrico Gregori vedere scandagliare, capire la morte altrui è come una barriera che tiene la morte lontana da noi.
La paura è uno dei nostri principali strumenti di difesa utile ad attivare quelle reazioni indispensabili per sopravvivere a una serie di attacchi che quotidianamente, nostro malgrado, siamo costretti a subire.
Secondo uno studio compiuto da Eduardo Andrade della University of California, insieme a Joel B. Cohen della University of Florida, sul perché ci piace tutto ciò che fa paura, si è scoperto che di fronte ad un film dell’orrore gli spettatori sono “felici di essere infelici”. Praticamente, godono delle esperienze negative, traendone beneficio dal sapere che si tratta di finzione e che quindi, concretamente, non procurerà alcun pericolo. Ma, questa reazione, apparentemente immotivata, di piacere di fronte ad angoscia e terrore viene vissuta, anche nella realtà, come sostiene Kerry Ressler dello Yerkes National Primate Research.
Nella vita – reale – quando si prova paura si attivano aree del cervello legate alle emozioni, in risposta alla necessità di mettersi alla prova.
Fisiologicamente, la paura è racchiusa nell’amigdala, una parte del nostro cervello talmente antica da farci accomunare ai rettili: sollecitata dallo stimolo della paura mette in attività una serie di meccanismi nel nostro cervello e nel nostro corpo atti a produrre quegli ormoni che sono responsabili di reazioni quali, difesa, combattimento, fuga oppure, di compiacimento per il nostro coraggio di affrontare l’evento, convinti dall’esperienza, di poterlo superare.
Durante l’epoca fascista la “nera” era bandita perché era un dovere creare l’illusione di vivere in un paradiso.
Quando nacque la televisione chi vi lavorava era più attento e prudente nel divulgare i fatti , perché sentiva la responsabilità di ciò che andava diffondendo: la paura, appunto.
La tendenza inizia ad invertirsi negli anni ’70 e ’80: si incomincia a raccontare l’avvenimento nei minimi dettagli. Emblema di questo cambiamento di rotta fu il caso di Vermicino: nel giugno del 1981, Alfredino Rampi, un bimbo di sette anni muore dopo essere caduto in un pozzo artesiano mentre giocava con gli amici in una piccola frazione situata lungo la via di Vermicino, che collega Roma a Frascati. Fu il primo caso mediatico della storia della televisione italiana: una lunga diretta che tenne incollati agli schermi milioni di telespettatori per due giorni e due notti di speranza e orrore.
Quando succedono certe tragedie siamo interessati a conoscerne i tratti più cruenti, piuttosto che a comprenderne le dinamiche. Pensiamo al turismo dell’orrore che si è sviluppato intorno al pozzo di Avetrana, da cui venne estratto il corpo di Sarah Scazzi. Pensiamo alle nostre reazioni di fronte alle varie notizie, che rientrano nell’ambito della cronaca nera. Quando leggiamo di un marito che uccide la moglie, le taglia la testa e la seppelisce, a pezzi nel giardino intorno a casa il nostro interesse è pari a cento; se, invece, lo stesso marito decidesse di uccidere la moglie con il gas, il nostro interesse scenderebbe a zero.
Non sappiamo dire se oggi, siano aumentati i casi di cronaca nera, o se sia aumentato lo spazio ad esse dedicato: l’unica cosa certa è che i nostri tempi non sono peggiori di quelli passati. Semplicemente, grazie alle nuove tecnologie siamo in grado di sapere tutto e in tempo reale.
Per esempio, chi di noi, non sa cosa siano “luminol”, “scena del crimine” oppure cosa significhi “incidente probatorio”?
Siamo interessati agli orrori privati: i delitti di mafia suscitano interesse pari a zero di fronte ad una “sana strage famigliare”. Nel secondo caso, inevitabilmente, scatta in noi l’istinto di sopravvivenza. Siamo spronati a conoscere ogni dettaglio di quella strage avvenuta in un normale contesto familiare perché, in questo modo, affrontiamo e approfondiamo situazioni pericolose che potrebbero mettere a rischio – anche – la nostra tranquilla esistenza. Pensiamo a ciò che sta avvenendo a Brembate Sopra: dopo la scomparsa di Yara Gambirasio il paese si è mobilitato, per paura, di vedere ripetere in casa propria quello che di terrificante sta succedendo in casa del “vicino”. È scattato quel meccanismo di difesa atto ad esorcizzare un evento che, oggettivamente, potrebbe succedere in qualunque sana famiglia.

Oggi, però, il male è strumentalizzato per ottenere l’audience: purtroppo, certi programmi televisivi riducono omicidi e reati terribili a “gialli”, rispondendo così ad una mera legge di “mercato” che implica il fare notizia ad ogni costo. In questo modo il rischio è quello di deformare i fatti: l’evento di cronaca è snaturato dal dramma, si stacca dalla reale sofferenza per trasformarsi nel becero gioco del se fosse.
L’audience, infatti, spinge, attraverso meccanismi collaudati, giornalisti e cronisti a tingere di giallo anche avvenimenti che di enigmatico hanno poco o nulla, facendoci dimenticare che il male e la complessità che sottende, la sofferenza che produce non sono merce da spettacolo. Il male, altro non è, che la sottile linea che divide la follia dalla malvagità
- VIA
- laredazione